Un po’ di astronomia
L’accelerazione della rotazione terrestre: dati e implicazioni. Cosa sta succedendo e cosa comporta. Quali sono le date critiche.
L’accelerazione della rotazione terrestre rende alcune giornate più corte: a influenzarla è la Luna e anche i cambiamenti climatici. Cosa sappiamo?
Negli ultimi decenni, la durata del giorno terrestre ha mostrato variazioni sempre più evidenti. Secondo i dati raccolti dagli esperti dell’International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), la Terra ha iniziato a girare più rapidamente di quanto fosse mai stato registrato negli ultimi 50 anni. Questo cambiamento si traduce in giorni leggermente più corti rispetto ai canonici 24 ore.
La causa principale di questa accelerazione è legata a fenomeni naturali complessi, tra cui movimenti nel nucleo terrestre e variazioni nella distribuzione delle masse superficiali come ghiacciai e oceani. Questi fattori influenzano il momento angolare del pianeta, modificando così la sua velocità di rotazione.
Un dato particolarmente significativo riguarda l’ultimo record stabilito nel luglio 2022: quel giorno è stato il più breve degli ultimi decenni con una durata inferiore alle 24 ore standard di circa 1,59 millisecondi. Sebbene possa sembrare un valore minimo, questa differenza ha importanti ripercussioni sul sistema globale di cronometraggio.
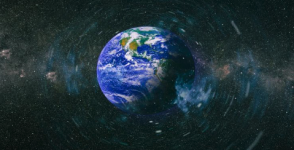
Conseguenze pratiche dell’aumento della velocità di rotazione
L’accorciamento dei giorni terrestri impone sfide notevoli soprattutto per i sistemi basati su orologi atomici estremamente precisi come quelli utilizzati nei satelliti GPS o nelle reti finanziarie internazionali. Per mantenere l’allineamento tra tempo civile e tempo astronomico viene periodicamente introdotto il cosiddetto “secondo intercalare”, ovvero un aggiustamento temporaneo degli orologi mondiali.
Tuttavia, con l’attuale tendenza all’accelerazione della rotazione terrestre la frequenza dei secondi intercalari potrebbe aumentare, complicando ulteriormente la gestione temporale globale. Alcuni esperti suggeriscono addirittura che in futuro sarà necessario rivedere completamente le modalità con cui si misura il tempo universale coordinato (UTC).
Inoltre questo fenomeno può avere effetti indiretti anche su altri ambiti scientifici come lo studio delle maree oceaniche o sull’equilibrio climatico planetario poiché ogni modifica nella dinamica interna ed esterna della Terra influenza vari processi ambientali fondamentali.
Gli scienziati hanno già individuato alcune date critiche in cui sono previsti ulteriori accorciamenti significativi nella durata del giorno terrestre entro i prossimi anni. In particolare entro fine anno è atteso un nuovo picco nell’accelerazione che potrebbe portare a giornate ancora più brevi rispetto al luglio 2022.
Questa situazione richiede quindi una costante attenzione da parte delle istituzioni scientifiche internazionali per monitorare tempestivamente ogni variazione ed adottare misure correttive adeguate nei sistemi tecnologici sensibili alla precisione temporale.
Il monitoraggio continuo tramite satelliti geodetici avanzati e stazioni terrestri specializzate rappresenta oggi uno strumento fondamentale per comprendere meglio le dinamiche interne alla Terra responsabili dell’aumento progressivo della sua velocità di rotazione.
In sintesi, mentre fino a pochi anni fa si pensava ad una possibile lentezza crescente nella rotazione planetaria dovuta allo smorzarsi graduale degli effetti lunari sulla Terra, ora emerge chiaramente uno scenario opposto: il nostro pianeta sta ruotando sempre più veloce. Imponendo nuove sfide scientifiche e tecnologiche senza precedenti negli ultimi decenni
Quanto durerà il giorno più corto della storia?
Si tratta solo di pochi millisecondi, che non hanno effetto alcuno sulla vita quotidiana degli abitanti del pianeta. Ma il cronometro del Servizio internazionale di Rotazione della Terra e dei Sistemi di riferimento e dell’Osservatorio nazionale degli Stati Uniti non lascia dubbi agli scienziati: la Terra quest’estate sta ruotando più velocemente, con giorni più “brevi” di ben 1,36 millisecondi nel caso del 10 luglio scorso, al momento il giorno più corto dell’anno.
Di recente, gli studiosi che sorvegliano gli orologi atomici di tutto il pianeta hanno osservato qualcosa di insolito: in alcune date, come il 9 luglio scorso, il 22 luglio e il 5 agosto, la durata di un giorno non ha raggiunto – o non raggiungerà – le consuete 24 ore. Si tratta di giornate più corte, accorciate di circa 1,3 – 1,5 millisecondi. Un battito di ciglia dura quasi cento volte di più, ma quando si parla di orologi atomici e sistemi di navigazione satellitare, anche un millisecondo conta.I 450 orologi atomici in funzione nel mondo garantiscono un tempo preciso: servono per coordinare GPS, telecomunicazioni e perfino operazioni militari. Se la rotazione terrestre non fosse monitorata così da vicino, potremmo avere problemi con le tecnologie che dipendono da una sincronizzazione millimetrica.
Non è la prima volta che si registra un cambiamento nel comportamento del Pianeta blu: nel 2020 la Terra ha cominciato a battere regolarmente record di rotazione tra giugno e agosto. “Dal 2020, la Terra registra giorni incredibilmente corti a metà anno, infrangendo i precedenti primati di circa mezzo millisecondo. Secondo gli osservatori, riporta oggi la Cnn, è un fenomeno “senza precendenti”.
La lunghezza di un giorno, vale la pena ricordarlo, è il tempo necessario affinché il pianeta completi una rotazione completa sull’asse (24 ore o 86.400 secondi in media). Ma in realtà ogni rotazione è leggermente irregolare a causa di una varietà di fattori, come la forza gravitazionale della luna, i cambiamenti stagionali nell’atmosfera e l’influenza del nucleo liquido della Terra. Di conseguenza, una rotazione completa richiede di solito leggermente meno o leggermente più di 86.400 secondi: una discrepanza di appena alcuni millisecondi. Una durate infinitesimale, ma una discrepanza che, a lungo termine, potrebbe influenzare computer, satelliti e telecomunicazioni, motivo per cui anche le più piccole deviazioni di tempo vengono monitorate utilizzando orologi atomici, introdotti nel 1955.

Un satellite nello spazio
Gli esperti temono, come conseguenze, uno scenario simile al problema del Y2K che minacciava, fra 31 dicembre 1999 e il 1 gennaio 2000, di fermare la civiltà moderna. Gli orologi atomici contano le oscillazioni degli atomi mantenuti in una camera a vuoto all’interno dell’orologio stesso per calcolare 24 ore con il massimo grado di precisione. Chiamiamo il tempo risultante UTC, o Tempo universale coordinato, che si basa su circa 450 orologi atomici ed è lo standard globale per la misurazione del tempo. E il tempo a cui sono impostati tutti i nostri telefoni e computer.
Sopravvissuti al millennium bug, e circondati dallo scetticismo o peggio dal negazionismo sul cambiamento climatico e addirittura indifferenti sull’evenienza dell’estinzione umana, forse l’idea che i nostri Gps e telefonini possano impazzire ci farà alzare gli occhi dagli stessi, verso una volta celeste sempre più parte della vita terrena. Ma forse avverrà troppo lentamente rispetto a una Terra che corre.
Il ruolo sorprendente della Luna
Ma perché la Terra accelera? La spiegazione principale va cercata proprio sopra le nostre teste: nella Luna. Questo satellite, da miliardi di anni, regola le maree e influenza la rotazione della Terra stessa. La sua orbita, oltre a essere ellittica, è anche inclinata rispetto all’equatore. Quando la Luna si trova più lontana – all’apogeo – di solito tende a frenare la rotazione, ma se l’inclinazione raggiunge il massimo, come nei giorni individuati dagli studiosi, può produrre l’effetto opposto.
Ecco perché l’influenza della Luna sulla rotazione terrestre è una delle cause più probabili di questa accelerazione. È una “danza cosmica” perfetta: la posizione e l’angolazione della Luna funzionano come un interruttore, capace di rallentare o velocizzare il nostro pianeta.
Terremoti, clima e altri fattori nascosti
Non è solo la Luna a incidere sulla Terra che gira più velocemente. Anche i terremoti possono alterare la distribuzione della massa interna, proprio come una pattinatrice che cambia la velocità girando le braccia. Nel 2005, ad esempio, un forte terremoto in Indonesia ridusse la durata del giorno di pochi microsecondi.
Inoltre, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento degli oceani possono spostare l’asse terrestre. Tuttavia, in questi casi l’effetto non è un’accelerazione, ma un rallentamento. Alcuni studi dimostrano che lo spostamento dell’asse terrestre, dovuto al riscaldamento globale, allunga le giornate di qualche millisecondo in un secolo. Anche la crescita delle foglie in primavera sposta la massa verso l’alto ma, di nuovo, si tratta di un freno, non di un acceleratore.
Cosa ci insegna questa scoperta?
La notizia che la Terra sta girando più velocemente ricorda quanto siano delicate le forze che regolano la nostra vita quotidiana. Anche se questa variazione è impercettibile per la maggior parte di noi, la precisione del tempo è fondamentale per navigare, comunicare e fare ricerca.
Per ora, la spiegazione più plausibile resta legata all’influenza della Luna sulla rotazione terrestre, anche se gli studiosi continueranno a monitorare il fenomeno con la massima attenzione. Dopotutto, il nostro pianeta e il suo satellite “danzano” insieme da 4,5 miliardi di anni. Se oggi assistiamo a giornate più corte è solo un piccolo capitolo di una storia cosmica molto più grande.
Perché si sono viste poche stelle cadenti a San Lorenzo, la Luna ha interferito
C’è stata una notevole interferenza della Luna durante le Perseidi 2025, o stelle cadenti di San Lorenzo: ecco perché se ne sono viste così poche
La notte di San Lorenzo 2025, attesa da migliaia di appassionati di astronomia e romantici, ha riservato una sorpresa meno spettacolare del previsto. Lo sciame meteorico delle Perseidi, famoso per offrire decine di scie luminose ogni ora, è stato quest’anno meno generoso. Il colpevole? Una Luna gibbosa calante che, con la sua intensa luminosità, ha ridotto sensibilmente il numero di meteore visibili. Un fenomeno naturale che unisce bellezza e scienza, ma che ha giocato contro a chi sperava di ammirare uno spettacolo celeste senza interferenze.
Le Perseidi e la loro origine

Le Perseidi sono uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. Ogni estate, intorno al 10 agosto, la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dalla cometa Swift-Tuttle (ufficialmente 109P/Swift-Tuttle), che ha effettuato l’ultimo passaggio vicino al nostro pianeta nel 1992.
Quando queste minuscole particelle entrano nell’atmosfera terrestre a velocità elevatissime, si incendiano per attrito, dando vita alle cosiddette stelle cadenti. Sebbene i frammenti provengano dalla cometa, la prospettiva dalla Terra fa sembrare che partano tutti da un unico punto nel cielo, situato nella costellazione di Perseo, da cui deriva il nome dello sciame.
La luce lunare e il suo impatto sullo spettacolo
In condizioni ideali, lontano dalle luci artificiali e sotto cieli limpidi, le stelle cadenti di San Lorenzo 2025 avrebbero potuto regalare fino a 40 o 50 meteore visibili all’ora. Tuttavia, la presenza della Luna dello Storione proprio nelle ore centrali della notte ha modificato lo scenario. La sua luce intensa ha ridotto il contrasto del cielo, cancellando dalla vista le meteore più deboli e lasciando percepibili solo le più luminose. Il risultato è stato un numero stimato di appena 10 – 20 scie visibili ogni ora, un calo significativo rispetto alla media.
Il fenomeno non è raro: quando la fase lunare coincide con il picco delle Perseidi, l’osservazione diventa più difficile. La luce della Luna funziona come un gigantesco faro naturale, diffondendosi nell’atmosfera e impedendo ai nostri occhi di adattarsi completamente al buio. Per gli astronomi e gli astrofili più esperti, questa è una sfida che si ripete ciclicamente e che può essere mitigata solo scegliendo i momenti e i luoghi di osservazione più adatti.
L’orario migliore per osservare e i consigli degli esperti
Nonostante l’interferenza, alcuni osservatori sono riusciti a godersi lo spettacolo scegliendo orari e condizioni ottimali. Gli specialisti, per un paio di giorni, raccomandano di puntare la sveglia tra le due e le tre del mattino, quando la radiazione luminosa della Luna è leggermente più bassa e il radiante delle Perseidi è ben visibile. Cercare un luogo rurale, lontano dalle città, permette di evitare l’inquinamento luminoso artificiale, che sommato a quello naturale della Luna peggiora ulteriormente la visibilità.
Un altro trucco è distogliere lo sguardo dal disco lunare: fissarlo riduce la sensibilità degli occhi alla luce debole, proprio quella delle meteore meno brillanti. Così, anche nelle prossime notti, si potrebbe cogliere qualche scia imprevista e particolarmente luminosa.
Un fenomeno che ritorna ogni anno
Il fatto che quest’anno lo spettacolo sia stato parzialmente offuscato non diminuisce l’importanza scientifica e culturale delle Perseidi. Lo sciame tornerà, come sempre, l’anno prossimo, quando la posizione della Luna potrebbe essere più favorevole, regalando un numero maggiore di meteore visibili anche a occhio nudo.
Le stelle cadenti rimangono un appuntamento con il cosmo che unisce scienza e poesia. Anche se le Perseidi 2025 hanno mostrato meno scie del solito, chi ha avuto la pazienza di cercarle lontano dalla luce ha potuto comunque percepire la bellezza di un fenomeno che da secoli accompagna le notti di mezza estate.
La Via Lattea potrebbe trovarsi in una grande bolla di vuoto, l’ipotesi supportata dallo studio del ‘suono’ del Big Bang di Elisa Buson

La Via Lattea (fonte: NASA)
La Terra e l’intera Via Lattea potrebbero trovarsi all’interno di un enorme vuoto cosmico, una sorta di bolla all’interno della quale la velocità di espansione è maggiore che all’esterno: a supportare questa ipotesi è lo studio del ‘suono’ del Big Bang, condotto dagli astronomi Indranil Banik dell’Università di Portsmouth e Vasileios Kalaitzidis dell’Università di Sant’Andrea nel Regno Unito.
I risultati, pubblicati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, sono stati presentati al convegno della Royal Astronomical Society a Durham.
La teoria rappresenta una potenziale soluzione alla ‘tensione di Hubble’, ovvero la discrepanza tra le misurazioni della velocità di espansione dell’universo, ottenute tramite osservazioni di supernove di tipo Ia nell’universo locale, e quelle derivanti dai dati relativi all’eco del Big Bang, ovvero la radiazione cosmica di fondo rilevabile nelle microonde. “Una possibile soluzione è che la nostra galassia si trovi vicino al centro di un grande vuoto locale, spiega Banik. “Ciò causerebbe un’attrazione gravitazionale della materia verso l’esterno del vuoto, a maggiore densità, tale per cui ‘il vuoto si svuota’ nel tempo. Man mano che il vuoto si svuota, la velocità degli oggetti che si allontanano da noi sarebbe maggiore rispetto a quella che si avrebbe se il vuoto non ci fosse. Questo dà quindi l’impressione di un tasso di espansione locale più rapido”.
Affinché l’idea regga, la Terra e il Sistema solare dovrebbero trovarsi vicino al centro di una bolla con un raggio pari a un miliardo di anni luce e una densità inferiore del 20% rispetto alla media dell’universo. Effettivamente, il conteggio diretto delle galassie nel vicino infrarosso supporta tale ipotesi, poiché la densità dell’universo locale sembra essere inferiore rispetto a quella delle regioni limitrofe. Tuttavia, l’esistenza di un vuoto così vasto e profondo è controversa, poiché non si accorda facilmente con il modello cosmologico standard secondo il quale la materia, su scale così grandi, dovrebbe essere distribuita in modo più uniforme.
Nonostante ciò, i nuovi dati presentati nello studio mostrano che l’eventualità di un vuoto locale ben si accorda con il ‘suono’ del Big Bang, ovvero le oscillazioni acustiche barioniche (Bao), fluttuazioni nella distribuzione della materia ordinaria nell’universo create dalle onde di pressione che si propagavano nel plasma primordiale. Queste onde, simili a onde sonore, hanno lasciato un’impronta nella distribuzione della materia e fungono da righello per tracciare la storia dell’espansione cosmica. “Considerando tutte le misurazioni delle Bao disponibili negli ultimi 20 anni – sottolinea Banik – abbiamo dimostrato che un modello con un vuoto è circa cento milioni di volte più probabile rispetto a un modello senza vuoti”.


