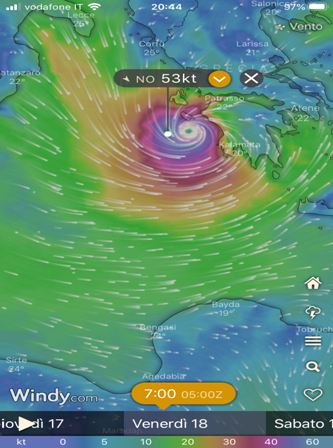DAFNE, la mia prima barca, racconto di Nunzio Platania, detto il VATE – parte5
CAPITOLO QUINTO
dove si dimostra che non basta trovarsi in patria per scapolare i guai

 Tornai dopo qualche giorno e cominciò il viaggio sul patrio mar.
Tornai dopo qualche giorno e cominciò il viaggio sul patrio mar.
Dovete sapere che in Sicilia a metà settembre la gente va ancora in maniche corte e le spiagge sono ancora affollate; da sempre, eccetto quell’anno.
Già l’indomani dell’ultima strizzatina alle mie visceri, il cielo si oscurò, nuvolacce nere cominciarono a rumoreggiare e per fare cosa gradita al sottoscritto, praticamente cominciò l’inverno.
Ma stavolta mi ero organizzato alla grande: la moglie mi seguiva in macchina; stabilivo la tappa successiva e la sera ci si incontrava nel porto designato e si dormiva in barca.
Ma ,giusto per tenersi in allenamento, in verità, una volta su due non ci si incontrava affatto, vuoi perchè a causa del maltempo ero costretto ad atterrare altrove dal luogo convenuto, vuoi perchè il luogo convenuto non aveva porto, vuoi perchè più semplicemente non lo trovavo a causa della scarsa visibilità, ogni sera erano patemi d’animo e lungaggini a non finire.
Una nostra amica veneta era venuta in Sicilia in ferie e si era aggiunta alla comitiva autovelica con l’ingenua convinzione di potersi divertire. Fu lei la protagonista del primo fantozziano episodio.
L’avevo imbarcata per una tappa che, seppur col cielo plumbeo, doveva essere tranquilla.
Accadde invece che la poverina soffrì il mal di mare, il quale mare quel giorno si mise senza preavviso al tempo”andante con moto”.
Decisi quindi di sbarcarla prima, in una località nei pressi di Licata, dove la mia nuova fiammante carta nautica siciliana riportava esserci un piccolo riparo.
Accosto quindi per farla scendere ad un moletto lillipuziano con sopra gente del posto che, dalla faccia che faceva, dimostrava di non avere mai visto avvicinarsi un barchino a vela come il mio a quell’attracco fatiscente.
Il moletto mancava completamente di alcunchè somigliasse ad una bitta o similaria,per cui mi risolvo di fare un trasbordo volante.
E volante fu…nel senso che Silvana volò in acqua.
Mentre infatti si accingeva a balzare a terra un’ondicina cattivella solleva la barca e la deposita graziosamente su un bel lastrone di pietra che stava proprio sotto il moletto, poggiandola sul bulbo e sbilanciandola bruscamente, trasformando così la già ardua impresa della mia amica in un tuffo all’indietro.
Naturalmente io avevo un bel da fare per tirare fuori dall’impiccio la mia non più dislocante barchetta e inoltre dovevo usare il motore, per cui ingiungo alla naufraga di togliersi di torno e di raggiungere a nuoto uno scoglietto che stava a qualche metro di distanza.
Cosa che la poverina, che non sapeva quasi nuotare, fece, remando in verticale come di solito fanno i candidati all’annegamento.
Sfinita da quei cinque metri di percorso oceanico, la nostra eroina non vide l’ora di abbracciare calorosamente lo scoglietto succitato, il quale, bontà sua, era costituito interamente da una colonia di meravigliosi ricci di mare che gradirono l’abbraccio affettuoso e ricambiarono con quindicimila aculei che trafissero l’incauta nuotatrice dal collo fino all’alluce del piede.
Colma di tanta generosità la nostra restò appollaiata sullo scoglio, senza profferire
verbo fino a quando, con l’aiuto degli indigeni che nel frattempo si erano resi parte attiva del dramma, ancorai alla meglio la barca e accorsi in aiuto alla sventurata.
Io, di spine di ricci nel corso della mia vita ne avevo tolte dalle mie e altrui carni a milioni.
Ma in trent’anni.
Calcolai che me ne occorrevano altrettante per estirpare quella foresta che spuntava dalla pelle di Silvana, facendole assumere l’aspetto di una riccia con sembianze umanoidi.
Allarmatissimo decido quindi di trasferirla a terra e cercare un pronto soccorso.
Sennonché il soccorso in quella landa desolata non era affatto pronto.
Ma accadde che, sparsosi la voce nel paesotto, un centinaio almeno di vecchiette, tutte
rigorosamente vestite di nero, armate di olio di oliva caldo e aghi di tutte le misure, di tenaglie e pinzette, attorniarono la mia singhiozzante amica che fu amorevolmente adagiata sul letto di una casa ospitale e per tutta la giornata,tra ululati di gioia e confortanti nenie di sabba di streghe, svestirono la malcapitata dal suo echinodermoso abito nero.
Silvana ripartì qualche giorno appresso fasciata come una mummia …la rividi solo dopo 10 anni.
Continuammo a fare tappe giornaliere che però a causa del maltempo non andavano in media oltre le 15-20 miglia al giorno e io cominciavo a disperare di arrivare prima o poi
a Catania.
Arrivai alla conclusione che quel sistema di incontri serali, con tutti i disguidi che nascevano, rallentava la già faticosa marcia e la preoccupazione di non preoccupare mia moglie, che ogni giorno mi vedeva partire senza la certezza di rivedermi la sera, era un ulteriore fardello e allungava i tempi morti del viaggio, per cui rispedì macchina-moglie a casa e decisi di cavarmela da solo.
A Gela il maltempo si placò.
Mi riposai un giorno intero e la sera, di nuovo tiepida e stellata, mi invitava a fare la prima navigazione notturna.
Il faro di Scoglitti lumeggiava chiarissimo nella notte, dall’altra parte del golfo di Gela a poco più di una quindicina di miglia.
Una leggera brezza al traverso sembrava assicurare una navigazione tranquilla, avevo anche dormito durante la giornata, per cui mi risolsi…vela pura in notte tardoestiva.
Un sogno…le prime ore li godetti veramente.
Ma essendone passate un po troppe di ore, cominciò ad impensierirmi il fatto che la luce del faro era tale e quale quella della partenza, nonostante che la barca procedesse abbastanza bene.
Ora l’esperienza di tutti i giorni mi induceva a ritenere che più ti avvicini a qualcosa, più la qualcosa deve ingrandirsi e siccome il faro si ostinava ad apparirmi costantemente uguale a se stesso, cominciai a congetturare di correnti contrarie.
Dopo quattro ore ero allarmato, non c’era luna ed era veramente buio, solo quel puntolino che ammiccava enigmaticamente.
Ad un tratto con la coda dell’occhio…vvvrrrummm…un’ombra nera, immensa, sfreccia alla mia sinistra rasentando la barca, seguita lestamente da un’altra ancora più sinistra, alla mia destra. “Uccelli enormi….” “Bestie arcane uscite dalle tenebre del mare per punire l’incauto navigatore che ha sfidato la sacralità del mare notturno”
Credo che tutti i mostri delle mitologie e delle leggende di cui avevo letto abbondantemente, attraversarono in un baleno la mia fantasia eccitata.
Spaventatissimo afferro la mia torcia subacquea, modello Vega, a cui si era rotto il pulsante di accensione e che io avevo riparato mettendo al suo posto un bel chiodo, e proprio nell’attimo in cui con concitazione spingo l’improvvisato interruttore, sbbrrammm….la pala del timone si solleva avvisandomi di aver toccato il fondo, il colpo secco mi sbilancia, mi catapulta con tutto il mio peso contro la paratia della cabina e il famigerato chiodo mi trapassa letteralmente il pollice.
Dolorante e sanguinante, illumino la zona : ero in mezzo ad una selva di faraglioni, pinnacoli e spuntoni di roccia che mi circondavano per 360 gradi e attraverso i quali ero passato con soave baldanza accompagnato dalla allucinata visione di mitologici volatili.
Ero arrivato a Scoglitti e in quell’istante seppi perchè si chiamava così…
Il dolore al dito era davvero lancinante, ma era sovrastato dalla angoscia del peggio, sicchè mi precipitai a calare l’ancora che andò giù per un pelo d’acqua sotto la prua assieme ad un quartino di litro del mio sangue, poi ammainai la randa, tentai di dare conforto al mio dito ululante e aspettai l’alba.
Appena arrivò la luce, mi resi conto di essere a qualche centinaio di metri dall’imbocco del porto in mezzo ad una secca paurosa e solo una fortuna sfacciata poteva avermi accompagnato fin li senza fracassare tutto.
Il timone era letteralmente schizzato fuori dalle femminelle, rompendo il fermo dell’agugliotto che era volato in mare. La barca con l’ancora sulla verticale della prua,era immobile in uno specchio d’acqua poco più grande della sua lunghezza; non c’era un alito di vento per cui mi risolsi di andare a cercare il fermo dell’agugliotto che doveva essere nei dintorni. Mi tuffai mettendo a dura prova il mio martoriato dito, ritrovai il mio prezioso pezzo d’acciaio che luccicava indifferente accanto al bel pietrone che aveva dato lo stop alla mia veleggiata notturna. La pala :una solenne ammaccatura sul bordo anteriore.
Poi, facendo lo slalom, usci dalla petraia e mi andai ad infilare in quel desolato porticciolo dall’ammiccante faro traditore.
In giornata mi spuntò un febbrone cavallino che mi suggerì con fermezza una opportuna
sosta sanitaria.
Il dito si era infettato e nel delirio, quella notte, sognai di battaglie aeree tra uccelli bianchi, a forma di barche con tanto di randa e trinchetta, che volteggiavano e lottavano nel cielo con uccellacci neri a forma di asteroidi (qualcuno aveva anche l’aspetto delle mazze da combattimento medievali, con tanto di aculei e rostri uncinati) .
Tra planate e cabrate sfrecciavano sfiorandosi le eterne schiere del bene e del male.
Quando mi svegliai ebbi la certezza assoluta di aver avuto la rivelazione definitiva
sulla nascita dei miti, le leggende sul mare e tutta la cosmogonia celeste:
La madre è sicuramente la strizza, sul papà non mi pronuncio.

………….5continua……………………………